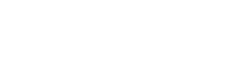La Luce Del Colore
di Marina Pizziolo
L’assenza delle cose restituita da una pennellata larga e festante.
La gioiosità del colore come mezzo per restituire poesia alla visione.
Questa la nuova luce che si è accesa, vibrante, nelle pagine pittoriche di Giovanni Vattimo.
Una crescita coerente, nel solco di quell’appassionata adesione al dato naturalistico che contraddistingue fin dalle prime prove il cammino pittorico di questo artista. La griglia semantica costituisce infatti per Vattimo la proiezione del piano dell’esperienza, che non può ontologicamente esprimersi se non per segni. E quale il segno universalmente riconoscibile e colloquiante, se non quello della natura?
Questa la ragione dell’ostinata ricognizione di compiute pagine del naturale, colte con la stupita poesia della scoperta. Un’indagine che ha sempre rifiutato di approdare all’immanenza della materia, alla physis, e si è rivolta invece alla mutevole superficie delle cose, al racconto del loro divenire. Vattimo, per intendersi, non ha fatto sprofondare il piano della visione fino all’intima essenza del naturale, come ha fatto ad esempio un altro lombardo, Ennio Morlotti, teso alla reinvenzione di una scrittura del naturale, nel segno di quella trepidante riscoperta della realtà dietro le cose che lo avvinse intorno alla fine degli anni Cinquanta. No, Vattimo ha preferito appuntare il suo sguardo sulla superficie, per non perdere la temporalità delle immagini, per non affondare nell’immagine senza tempo della materialità delle cose. Ha preferito mantenere la distanza che consente di vedere intera la natura, di vederla mutare, trascolorare di stagione in stagione, intonarsi ai colori del cielo.
Questo per diversi anni. Anni in cui la sua fedele scrittura del naturale evitava persino le traslitterazioni cromatiche, accettando al massimo l’effusione tonale delle dominanti.
Anni di un’intima poesia del paesaggio, vissuto come specchio del proprio divenire. Poi l’incontro con Piero Maggioni, un artista che travolge le tranquille geometrie della terra di Brianza con la violenza espressionistica del colore, e la svolta. Nel maggio 1995, in occasione della mia prima presentazione critica di Giovanni Vattimo, salutavo così questo mutamento: “Partito da una puntuale descrizione naturalistica, Vattimo nelle ultime opere è approdato a una pennellata che scorre fluidamente tra le cose. La suggestione della pittura di Piero Maggioni si dispiega in una nuova, originale inventiva cromatica, che stria le terre di gialli squillanti e apre nei blu degli squarci di luce.
Finché, come nel gioco magico dell’apprendista stregone, l’artista rimane stretto in un vortice di forze che lui stesso ha evocato.
Il tramonto sui colli della Brianza non è più, allora, spunto per una pagina di commossa poesia, ma materializzazione dell’eterno conflitto tra le forze del bene e del male, che dilania sia l’uomo che la natura, scontro annunciato tra il giorno e la notte. Era questa tempesta, quest’esplosione di colore, forse, l’attesa inquieta, la promessa di quei primi paesaggi silenziosi”.
Ma il cambiamento non poteva limitarsi a una nuova tavolozza.
Il colore, che Vattimo usa ormai come medium esclusivo della propria espressività, ha finito con l’erodere i profili delle forme, che rifiutano il rigido confine della linea. La violenza dell’aggressione cromatica ha finito con l’imprimere alle forme una sorta di fibrillazione. Il rifiuto di affondare lo sguardo nelle trame della materia è diventato concitato racconto dell’apparenza, dell’impressione fulminea di una luce così forte da costringere a socchiudere gli occhi. Allora, ad occhi socchiusi, ecco che l’esaltazione cromatica restituisce le immagini delle cose ridotte a un’elementare trama di rapporti volumetrici. E’ lo scheletro del reale che prende finalmente forma.
Ma la reductio ad minimum preludono sempre a qualche altra scoperta perché rivelano nuove possibilità di sintesi, nuove progressioni. La prima è già visibile nelle ultime tele. Gli ultimi dipinti infatti sono composti su due tele accostate. La necessità di intervenire su uno spazio modulato, per ora limitata all’esigenza di una bipartizione planare dello spazio fisico dell’immagine, apre infatti la strada a un supermercato di tale planarità, a una diversa scansione dell’immagine nello spazio.
Del resto, dalla fedele trascrizione del dato naturalistico, Vattimo sta passando a una reinvenzione della natura. Non per misconoscere la sua primitiva esigenza di comporre secondo i ritmi di una meditata poesia della visione. Tutt’altro. Nei suoi ultimi lavori si avverte infatti l’ostinata volontà di cercare una nuova poesia, che se non può più esprimersi secondo i tradizionali parametri, deve comunque trovare la via per giungere al cuore della realtà.
L’alfabeto naturale rimane l’unico in grado di comunicare universalmente, occorreva però trovare un nuovo lessico in grado di recuperare e restituire intatta la novità della visione, avvilita e banalizzata, assurdamente, proprio dalla persistenza della straordinarietà delle sue forme. Questo, d’altra parte, è il fronte di tutti i realismi, è l’eterna, coraggiosa battaglia per la persistenza dell’immagine in arte. Più semplice per molti versi andare oltre - e questo secolo che sta per chiudersi ce ne offre ormai innumerevoli esempi - cercare la novità scardinando le coordinate del visibile.
Nell’esaltazione dei rapporti cromatici Vattimo ha trovato dunque la sua strada per superare l’usura della visione. Arduo tentativo quello di chiudere nel poco spazio di una tela il soffio dell’infinito.
Ancora più arduo oggi, per il confronto con la profondità illusoria dei monitor che schiudono continuamente ai nostri occhi nuove possibilità di visione. Forse però, se c’è ancora una possibilità di accorgersi del mondo, non è nell’ossessiva scansione di immagini dei teleschermi, né tra i flutti di Internet, ma nella fissità di un frammento del reale proposto da un dipinto.
Dietro al quale c’è sempre perlomeno, il sogno di un uomo.